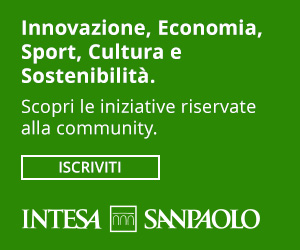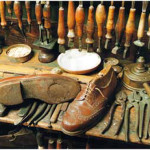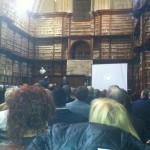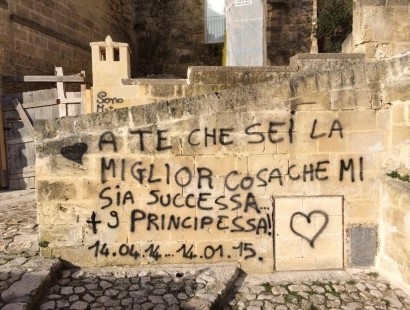Da circa 15 anni, sto cercando di recuperare e valorizzare il Castello Lauritano di Agerola, provincia di Napoli, sebbene ostacolato in ogni modo dagli amministratori locali che calpestano le norme del vigente Piano Regolatore. Questo prevede, infatti, interventi di “restauro scientifico e riuso del Castello Lauritano e dell’annessa area di belvedere per la realizzazione di attrezzature para-ricettive e di servizio da svolgersi prevalentemente all’aperto”.
L’articolo 86 della Normativa Tecnica allegata al P.R.G. per le zone A, in cui ricade il Castello , detta le seguenti prescrizioni: “Va perseguita la conservazione e il ripristino dei caratteri di articolazione volumetrica dei fabbricati esistenti”.
Nel Programma di Valorizzazione (redatto ai sensi della legge regionale n. 26 del 18/10/2002 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2003) il Castello Lauritano è incluso tra gli immobili di particolare interesse storico ambientale, per i quali si prevedono “interventi finalizzati al mantenimento dell’integrità materiale del bene e della conservazione e protezione dei suoi valori culturali. È uno dei cinque poli attrattori del Comune di Agerola. Gli interventi di valorizzazione riguarderanno il restauro e la riqualificazione del manufatto al fine di re-istituire il paesaggio storico”.
Alla luce della Normativa Tecnica vigente, appare evidente l’intento ostruzionistico attuato dall’Amministrazione Comunale di Agerola, tramite il responsabile del Servizio urbanistico, per boicottare gli interventi di valorizzazione. In questo modo, si danneggiano non solo i proprietari, ma l’intero paese in quanto il Castello dovrebbe essere un polo di attrazione per l’intero territorio.
Posto sul ciglio di un’alta parete rocciosa, a 700 metri sul livello del mare, il Castello Lauritano sovrasta l’intera costiera Amalfitana, a strapiombo sul Vallone di Santa Croce. Da qui si può godere una visuale piena sul promontorio di Conca dei Marini, sul Convento Santa Rosa (XI secolo) e sulla villa di Sofia Loren. Dal terrazzo del Paradiso, lo sguardo abbraccia l’intero Golfo di Salerno fino ai Monti Alburni e raggiunge il Cilento con Punta Licosa, lasciandosi dietro il Duomo di Amalfi e la Torre dello Ziro; sfiorando Ravello con il Parco e la Torre di Villa Cimbrone, ma anche il Duomo e la Piazza. Il terrazzo è dirimpettaio di Ravello, benché – essendo più in alto – consente una maggiore panoramicità. Questo è uno spettacolo unico al mondo, da non perdere!
Mi limiterò qui a illustrare gli ultimi ostacoli che riguardano il recupero di un portico crollato, indispensabile per la funzionalità dell’intera struttura. Il 20 settembre 2010 i Comitati tecnico-scientifici del Ministero per i Beni e le attività culturali, in seduta congiunta, hanno espresso il seguente parere: “I Comitati ritengono che si possa prendere in considerazione la riproposizione di una parte del portico crollato alcune decine di anni orsono, ma documentata fotograficamente”. Il 5 marzo dell’anno successivo, anche la Soprintendenza di Napoli (ai sensi dell’art. 21 del D.L. 42/04 del Codice dei Beni Culturali), ha espresso parere favorevole “all’intervento di ripristino e al recupero dei volumi crollati al piano terra del Castello Lauritano”. E infine, il 27 marzo 2012 il Responsabile della Tutela Paesaggistica rilasciava l’autorizzazione paesaggistica (Protocollo n. 2453).
Ma in data 25/09/2013 il Responsabile del Servizio Urbanistica, geometra Giovanni Milano, respingeva la richiesta di rilascio del permesso a costruire con la motivazione che “non è accertato, né accertabile tale preesistenza”. Eppure, esistono numerose fotografie, datate e timbrate, che dimostrano la preesistenza del portico. E inoltre i resti ancora presenti “in loco” lo confermano in modo indiscutibile.
Sono stato costretto perciò a ricorrere al TAR di Napoli che purtroppo, ignorando l’articolo 30 del cosiddetto “Decreto del fare”, e pur essendo la documentazione fotografica allegata alla pratica, ha sentenziato che esistono tracce minimali sull’esistenza del portico: motivo per cui non ha concesso la sospensiva. Questa è l’Italia che non riesce a progredire. E intanto la Francia ha il doppio dei turisti!
Antonio Mascolo (Agerola – Napoli)
ALLEGATI (click per visualizzare):
1. Destinazione Urbanistica
2. Foto