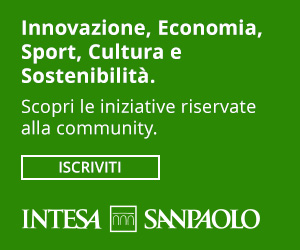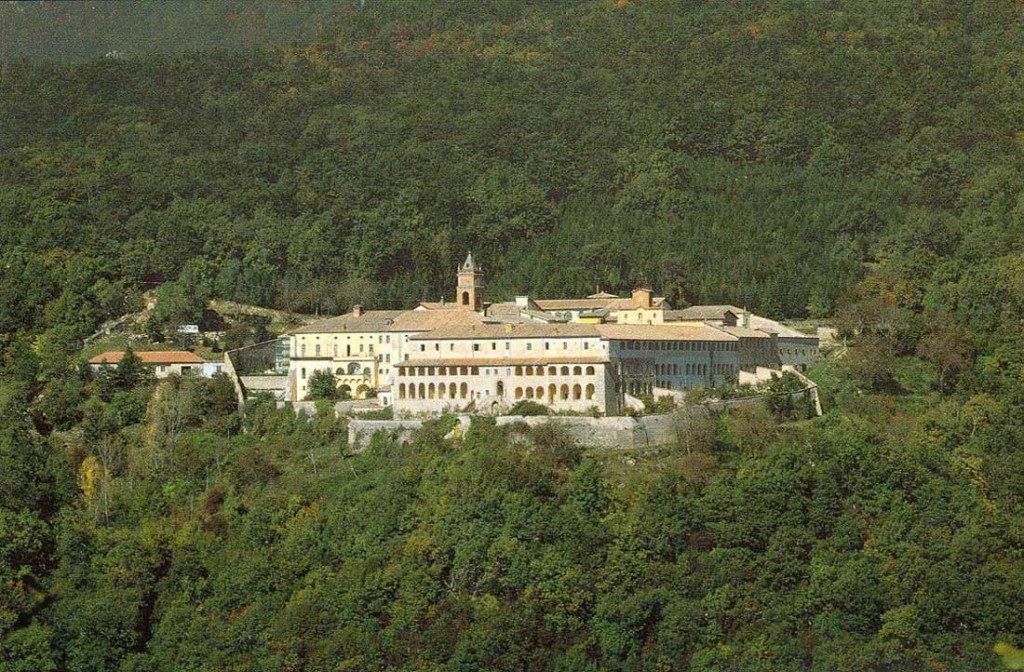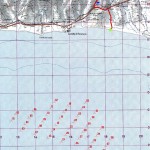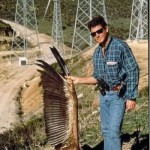È stata attribuita quest’anno alla Marina militare italiana la Targa d’argento della Fondazione “Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo”, per il suo “essenziale contributo dato per il salvataggio in mare di migranti”. Nel corso della settima Giornata su “Immigrazione e cittadinanza”, organizzata insieme all’Associazione “Investire in Cultura”, il presidente Emmanuele Emanuele ha consegnato il premio al Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che ha illustrato l’attività di soccorso e assistenza svolta dai reparti a bordo delle nostre navi militari.
«Da uomo mediterraneo, ispano-siciliano, abituato da sempre a una società multietnica, ho una propensione empatica nei confronti degli emigranti”, spiega il professor Emanuele: “E’ per questo motivo che la Fondazione che presiedo opera costantemente per aiutare i popoli del Mediterraneo nei loro Paesi; per creare le condizioni affinché nessuno debba più fuggire da un destino senza speranza, in un esodo verso l’Occidente e l’Europa che nessun muro potrà mai fermare. Fenomeno ben noto a noi italiani, che ha caratterizzato quasi cinquant’anni di storia patria, fatta di emigrazione massiccia verso le Americhe e l’Australia. Questa è l’unica strada per far cessare la tragedia dei barconi, dei lager dove teniamo di fatto prigionieri questi profughi, con la disumanità di un contrasto all’immigrazione che ci lascia sulla coscienza migliaia di morti, nonostante il prezioso e nobile operato della nostra Marina”.
È dal 2009 che la Fondazione “Terzo Pilastro” assegna questo riconoscimento ad associazioni ed enti che si sono particolarmente distinti per il loro impegno a favore di chi approda sulle sponde italiane, o arriva via terra nella nostra Penisola, da migrante o da rifugiato. Nel corso della settima Giornata su “Immigrazione e Cittadinanza”, docenti ed esperti si confronteranno per suggerire alle istituzionali nazionali nuove strategie su quest’argomento.
Argomento divenuto di stretta attualità, specialmente negli ultimi anni, il tema immigrazione è largamente dibattuto soprattutto per quanto riguarda la prima accoglienza e i tanti problemi che nascono dalle difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro. Purtroppo, la grande attenzione rivolta a questa drammatica realtà mette in secondo piano un argomento non meno importante che riguarda le future generazioni: e cioè il processo d’integrazione dei figli degli immigrati nati in Italia. Nel nostro Paese, com’è noto, esiste una forte spinta culturale e politica che tende a facilitare la concessione della cittadinanza, ma l’integrazione per trasformare questi giovani da ospiti in cittadini dipende fortemente dai rapporti interculturali e in particolare dall’azione fondamentale della scuola, nonché dall’apprendimento essenziale da parte degli immigrati delle nostre leggi e della nostra Costituzione.
Su iniziativa della stessa Fondazione “Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo”, il 16 aprile s’inaugurerà a Palermo (Teatro Politeama , Sala gialla – ore 18) una mostra storica e fotografica sull’immigrazione italiana nelle Americhe, intitolata “Partono i Bastimenti” e curata da Francesco Nicotra, direttore dei progetti speciali NIAF (National Italian American Foundation) che ha dato il suo patrocinio a questa esposizione in Sicilia. La rassegna, a cui prossimamente “Amate Sponde” dedicherà uno specifico approfondimento, è stata già allestita con successo a Napoli, a Cosenza, a Bari e in edizione ridotta presso il Ministero degli Affari esteri a Roma.