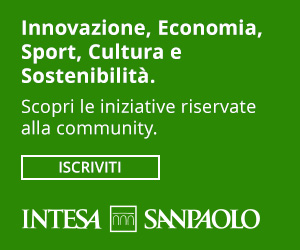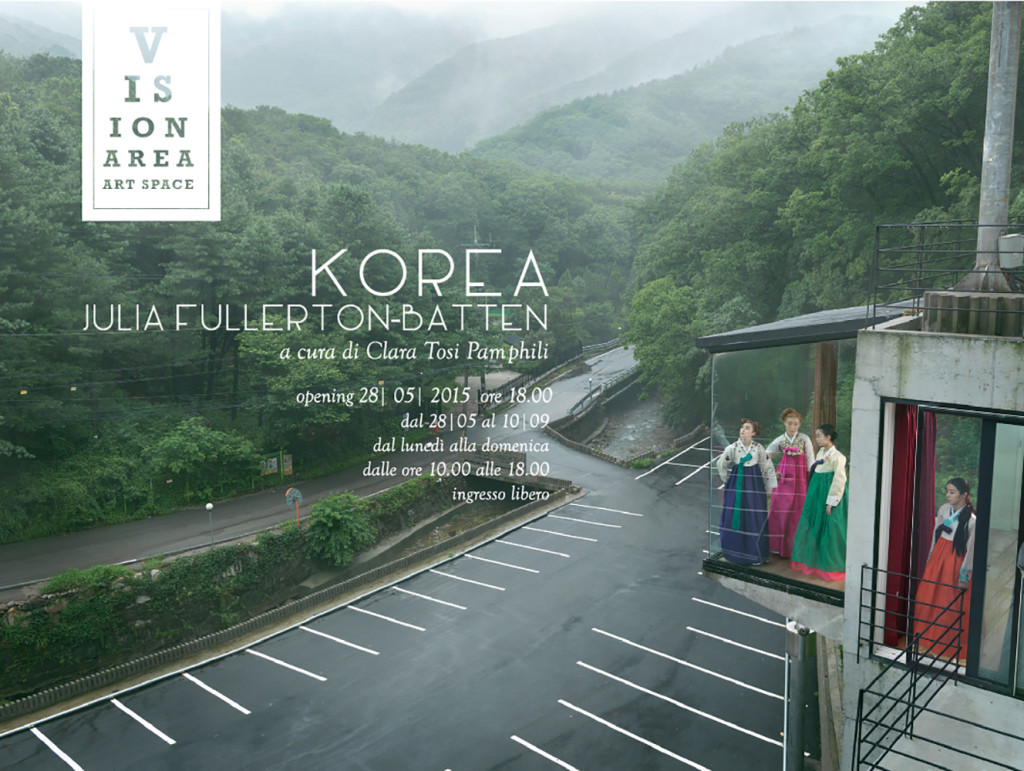“L’arte applicata al territorio come strumento per combattere il degrado”. Con questo input di Emmanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro, s’inaugura il 28 giugno ad Arezzo la terza edizione di “Icastica”, la rassegna internazionale che resterà aperta fino al 27 settembre.
Tra passato storico e presente autorevole, la kermesse aretina si occupa di linguaggi creativi nel tempo, dal materiale artistico al documento, dalla testimonianza all’esperienza. Per tre mesi, nel centro della città, sarà possibile ammirare e “vivere” le opere di oltre cento artistici contemporanei tra i più significativi della scena mondiale, legate ai capolavori di Cimabue, di Piero della Francesca e Giorgio Vasari, in quasi quaranta sedi interne ed esterne.
Fra le testimonianze di maggior rilievo, c’è anche la “street art” che ha valorizzato le facciate di numerosi edifici di Tor Marancia a Roma, con l’esperienza di “Big City Life” promossa dalla stessa Fondazione Terzo Pilastro. “Questa – dice il professor Emanuele – è un’espressione artistica di grande vitalità ed efficacia comunicativa: non a caso oggi questo quartiere romano è più visitato dei grandi musei”.
Il filo conduttore di “Icastica”, come spiega l’art director Fabio Migliorati per l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Arezzo, tende a coniugare il Vero del paesaggio con il Buono del cibo e il Bello dell’arte: “Un trittico delle meraviglie deliziose che rappresenta la Cultura coltivata”.
È proprio in questo senso che la rassegna aretina – articolata in tre sezioni: Iconic, Project ed Event – si collega all’Expo 2015 di Milano, l’Esposizione universale imperniata sull’alimentazione. Si tratta di una questione fondamentale per il futuro dell’intera umanità, come ha ammonito nei giorni scorsi Papa Francesco con la sua enciclica “Laudato sì” in chiave ambientalista.