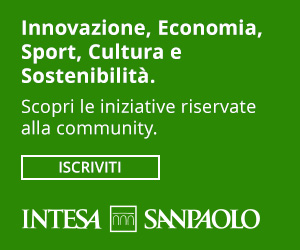Fu il socialista Giorgio Ruffolo, quando divenne ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel 1987, a coniare lo slogan “chi inquina, paga”. Era un principio – rivoluzionario, per quell’epoca – che puntava a responsabilizzare gli italiani, e in particolare gli imprenditori e gli altri operatori economici, nei confronti dell’inquinamento ambientale e della salute collettiva. Sono passati quasi quarant’anni e purtroppo dovremmo capovolgere quello slogan, per dire “chi inquina, non paga”.
Le bonifiche dei siti inquinati segnano il passo. Sono meno di 8mila ettari di territorio, su quasi 150mila, pari ad appena il 6% di suolo, quelli che risultano risanati. E ancor meno le falde bonificate, pari ad appena il 2%. Un’emergenza ambientale che mette a rischio la salute di 6,2 milioni di persone, oltre il 10% della popolazione nei siti nazionali e regionali.

A lanciare l’allarme è il rapporto “Ecogiustizia subito: nel nome del popolo inquinato” delle associazioni, laiche e cattoliche, che hanno promosso una campagna itinerante di denuncia in tutt’Italia: Acli, Agesci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera. L’iniziativa è stata praticamente ignorata dai principali giornali italiani, con la lodevole eccezione di Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale, che ha pubblicato recentemente un nuovo articolo a firma di Luca Liverani. Sull’argomento è intervenuta anche Confindustria, rilevando che una grande operazione di risanamento potrebbe alimentare fino a 200mila posti di lavoro.
Più in dettaglio, dei 148.598 ettari di aree inquinate, in 41 Siti di interesse nazionale (Sin), solo 7.972 sono stati finora bonificati. E appena 6.188 ettari (5%) hanno visto approvato il progetto di bonifica o di messa insicurezza. Ancora peggio per le falde acquifere: solo il 23% di quelle sotterranee è stato “caratterizzato”, con la definizione della tipologia e dell’inquinamento; mentre appena il 7% ha un progetto di bonifica approvato.

Ma quali sono i motivi di questo degrado che penalizza il territorio nazionale e minaccia la salute pubblica? L’articolista di Avvenire li riassume così: gravi ritardi negli iter amministrativi da parte degli enti locali, “per mancanza di mezzi, capacità, volontà”; poi, “una media bassissima di ettari bonificati all’anno”; e infine “la frequenza di reati di omessa bonifica”. Per quest’ultima voce, se ne registrano 35 su 241 controlli dal 1° gennaio 2015, l’anno della legge sugli ecoreati, fino al 2023: in media, un reato ogni 6,8 controlli. La graduatoria delle regioni, in questo campo, assegna la “maglia nera” alla Sicilia (17 reati), seguita da Lazio e Lombardia (5 a testa), al terzo posto la Calabria (3) e quarta la Campania (2).
Per accelerare le bonifiche, il Rapporto delle associazioni propone anche un piano dettagliato d’intervento, indicando 12 priorità in tre ambiti: “governance con aspetti normativi e procedurali”; “integrazione degli aspetti sanitari”; “reindustrializzazione per i piccoli lotti”. Riguardo agli impatti sulla salute, nelle aree inquinate – secondo uno studio dell’Istituo Superiore di Sanità – si registra “un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione rispetto al resto della popolazione”.
In una dichiarazione rilasciata ad Avvenire, Giuseppe Notarstefano, presidente dell’Azione Cattolica, avverte: “Non si può tornare indietro sulla visione della transizione ecologica, che mette insieme ciò che è utile con ciò che è giusto per un nuovo umanesimo”. E il presidente delle Acli, Emiliano Manfredonia, sottolinea che proprio l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco ha affermato il concetto di “ecologia integrale”: vale a dire, la difesa dell’ambiente legata alla giustizia sociale.